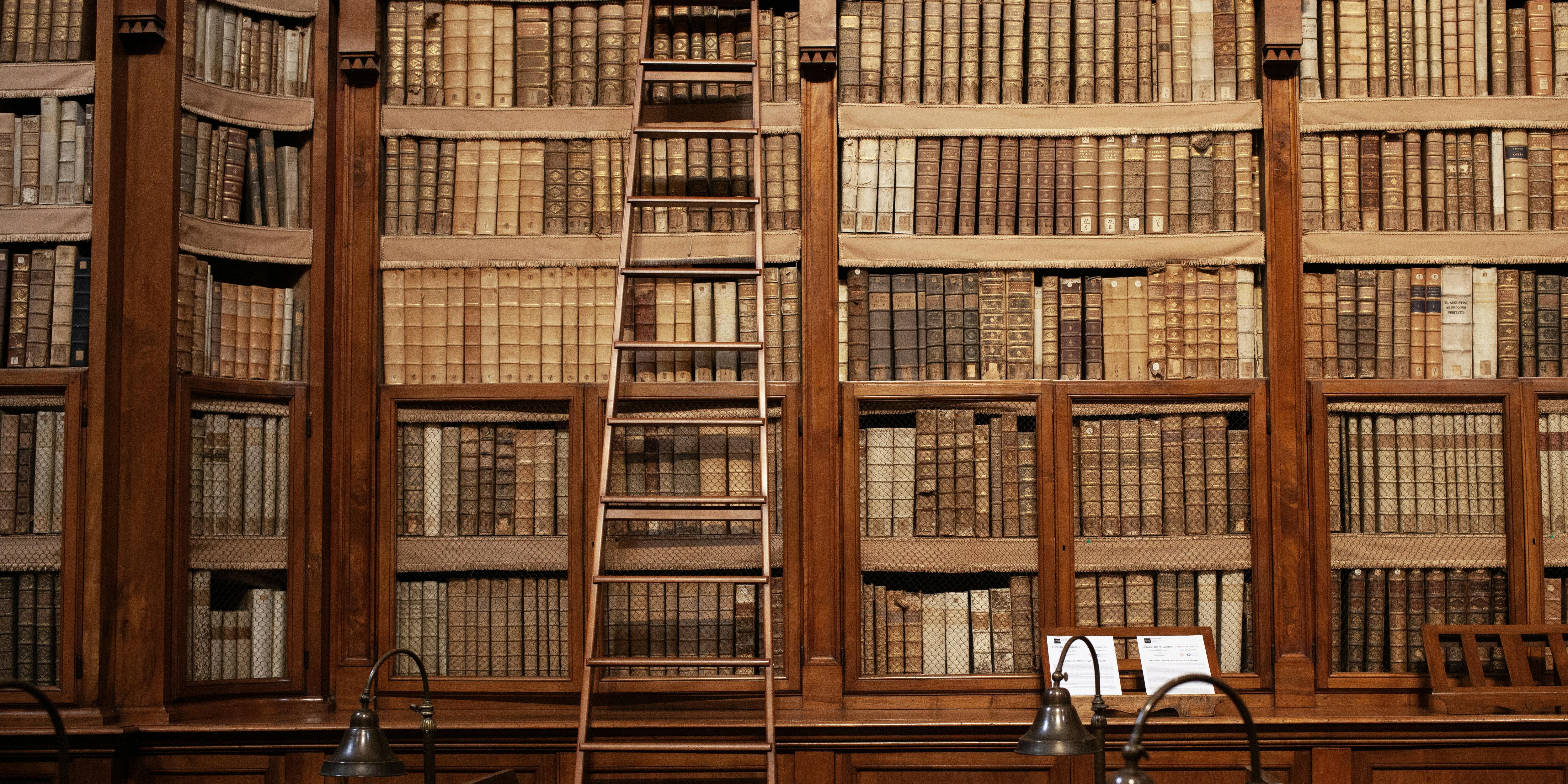
Che vuol dire MAB?
Digitalizzazione e soluzioni accessibili per la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale
La collaborazione tra musei, archivi e biblioteche ricorre nelle teorie come nelle pratiche poggiando sul presupposto che le tre tipologie di organizzazione, condividendo la missione di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale che collezionano, si rivolgano alle medesime comunità, offrano servizi similari e condividano prassi di lavoro.
In Italia, dal 2011 esiste MAB, «un coordinamento permanente per esplorare le prospettive di convergenza tra i mestieri e gli istituti in cui operano i professionisti degli archivi, delle biblioteche, dei musei», voluto da AIB (Associazione italiana biblioteche), ANAI (Associazione nazionale archivistica italiana) e ICOM (International Council of Museum, Italia). Queste istituzioni, infatti, affrontano quotidianamente sfide che si sovrappongono, dalle trasformazioni tecnologiche ai mutamenti sociali, che influiscono sul modo in cui il patrimonio è organizzato, gestito e reso accessibile.
È con l’avanzare delle tecnologie digitali che le diverse comunità di professionisti in dialogo hanno potuto davvero interagire così intercettando sorprendenti possibilità di conservazione e valorizzazione dei diversi patrimoni. Tuttavia, molto diversi sono gli ambiti disciplinari dei professionisti coinvolti e non sempre conciliabili i modelli di funzionamento e le pratiche di gestione e valorizzazione delle organizzazioni. Inoltre, nel nuovo ambiente digitale, competenze, ruoli, funzioni, processi di lavoro devono necessariamente essere riconfigurati e perché questo avvenga è necessaria una rinnovata complicità tra professionisti e organizzazioni.
Le sfide attuali: digitalizzazione e metadatazione, rappresentazione dei dati, studio dei pubblici digitali
Una delle priorità del coordinamento MAB è il superamento delle barriere culturali, organizzative e tecniche all’uniformità nei linguaggi descrittivi, per la creazione di ambienti digitali integrati e interoperabili. Altre due priorità riguardano la rappresentazione dei dati, per migliorare i modelli di architettura delle informazioni, e lo studio dei pubblici digitali, per un monitoraggio dei comportamenti e delle esigenze dei pubblici digitali, con l’obiettivo di migliorare l’accesso, l’esperienza e il riuso del patrimonio digitale.
Verso una convergenza digitale e strategica
Il PND Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale, promosso dal Ministero della Cultura, rappresenta una risorsa chiave per il MAB, proponendo un modello operativo che incoraggia un approccio sistemico. Tra i principi raccomandati, spiccano l’efficienza, l’efficacia e la trasparenza dei processi di digitalizzazione, punti essenziali per lo sviluppo di una memoria culturale integrata.
Affinché l’innovazione tecnologica diventi una forza trainante per le istituzioni culturali, il MAB promuove una 'prospettiva di convergenza', ovvero una strategia di sinergia che permetta a musei, archivi e biblioteche di collaborare efficacemente e di sfruttare le opportunità offerte dal digitale. Attraverso questa convergenza, il MAB si propone di sviluppare e diffondere pratiche per garantire che le competenze e le risorse digitali siano distribuite e accessibili, contribuendo così a una maggiore inclusione e consapevolezza culturale tra la popolazione.
Con il suo approccio inclusivo e lungimirante, MAB si rivela un’infrastruttura sociale oltre che culturale, capace di rispondere alle sfide di oggi e di domani. La rete lavora per garantire che il patrimonio culturale italiano rimanga non solo un’eredità, ma una risorsa attiva, valorizzata e condivisa.
Per approfondire il tema, è possibile consultare il PND Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale 2021 del Ministero della Cultura e visitare il sito ufficiale del MAB Italia, che offre un ampio ventaglio di risorse e documentazione strategica.
Il ruolo della formazione e dello scambio di competenze.
Un altro aspetto su cui il MAB si concentra è la formazione e il miglioramento delle competenze dei professionisti del patrimonio culturale. Questo avviene attraverso incontri, workshop e progetti comuni, dove le pratiche innovative vengono condivise e adattate. La formazione, così intesa, non è solo un mezzo per aggiornare le competenze, ma anche uno strumento per sviluppare una mentalità collaborativa e aperta alle innovazioni, rafforzando il concetto di rete.
Questo contenuto è rilasciato secondo i termini e le condizioni della licenza Creative Commons c.d. “Free Culture” – CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/); detta licenza consente, citando la fonte, di utilizzare e condividere i contenuti con qualsiasi mezzo e formato, nonché di trasformarli, per qualsiasi fine anche commerciale, e con facoltà di sub licenziare in futuro i contenuti ad altro editore, purché con le condizioni e i termini della medesima licenza CC BY-SA.
Diversi termini di titolarità e licenza sono indicati esplicitamente.